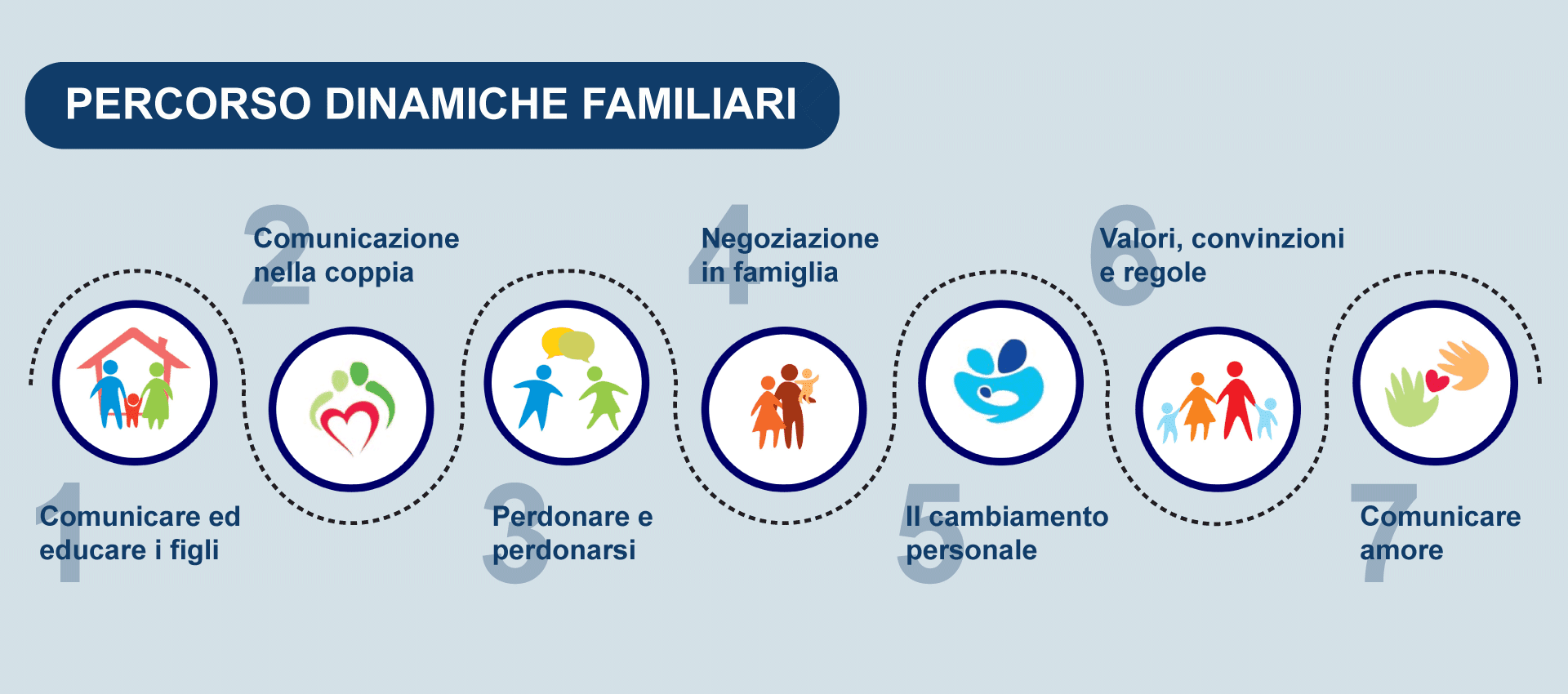Si sente sempre più spesso parlare di Intelligenza Emotiva ed è bene iniziare con il dire cosa sia: Daniel Goleman è stato il grande artefice della diffusione di questo termine con alcuni suoi libri, dal 1995 in poi, che sono divenuti best seller.
Ma se ne parlava già prima. Nel 1990 ci fu il primo articolo dove si usò questo termine.
L’intelligenza emotiva è l’abilità di percepire, valutare ed esprimere un’emozione: è l’abilità di accedere ai propri sentimenti o crearli quando facilitano i pensieri; l’abilità di capire l’emozione.
Detto in modo ancora più semplice è la capacità di percepire, valutare ed esprimere un’emozione.
La capacità di entrare in contatto con sé stessi.
Come svilupparla
Come allenare e stimolare l’intelligenza emotiva? Il modo più semplice è ponendo ai figli due domande in particolare:
1) cosa hai provato o cosa stai provando?
2) cosa immagini abbiano provato?
Nel primo caso c’è un ascolto di sé stessi e il riconoscimento dei propri stati emotivi, nel secondo caso c’è un’immedesimazione, c’è il mettersi nei panni di qualcun altro e immaginare cosa proveremmo fossimo stati nella loro stessa situazione.
Quando allenare l’intelligenza emotiva
Domande come queste, come per ogni altro lavoro di evoluzione, crescita e miglioramento personale, non si possono fare nei momenti concitati di discussione, scontro o rabbia.
Ogni lavoro di introspezione deve essere svolto nei momenti di calma, di tranquillità, mentre si chiacchiera piacevolmente sorseggiando un thè freddo sotto le fronde di un albero, mentre si passeggia, mentre si sta giocando a qualcosa e c’è lo spazio per parlare del più e del meno, mentre i figli ci raccontano di un qualche aneddoto della loro vita.
“Sai mamma che oggi Patrizia era convinta di prendere un bel voto e invece ha preso 5 e ha pianto?” di fronte ad una frase così, spesso i genitori, se fanno domande, sono di tipo pratico “Come mai ha preso 5? Cosa ha sbagliato? Tu avresti saputo rispondere a quelle domande?”.
Non sono certo domande sbagliate ma si concentrano su aspetti pratici senta tener conto dell’intelligenza emotiva.
Se l’intenzione è aiutare i figli a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio piano emotivo, si possono porre anche altre domande: “Secondo te cosa ha provato Patrizia quando ha preso 5?”, “Tu come ti sei sentita quando la tua amica ha pianto?”, “Durante l’interrogazione come sono cambiate le tue sensazioni dall’inizio dell’interrogazione a quando l’insegnante ha dato il voto?”.
Sono solo degli esempi e le domande possono essere molte e certamente non vanno poste a raffica come se fosse un interrogatorio.
Dietro ad ognuna di queste domande, i figli si trovano a dover compiere un lavoro di riconoscimento, confronto e analisi dello stato emotivo proprio e altrui.
Lasciate loro il tempo di pensare alle proprie emozioni, lasciate il tempo perché cerchino il proprio sentire, lo riconoscano e siano in grado di dargli un nome.
Il tuo compito è solo quello di scegliere una o due domande e “buttarle li” tra una chiacchiera e l’altra con nonchalance.
È molto probabile che all’inizio ti rispondano “non so” “boh” “non ho idea”: non ti arrendere. Sono le risposte più ovvie di chi non vuole fare la fatica di ricercare la risposta in sé. È naturale che provino a “scantonare” e cerchino la scorciatoia ma tu riponi la dimanda con sincera curiosità.
Giochiamo all’intelligenza emotiva
Si possono fare anche dei giochi: da molti anni in TV c’è una serie televisiva molto carina che si intitola “Lie to me” ed il protagonista è uno studioso che riconosce ogni microespressione del viso o gestualità del corpo per scoprire se le persone mentono.
La serie prende spunto da un personaggio reale, Paul Ekman (ha scritto molti libri: “I volti della menzogna” “Te lo leggo in faccia” “Giù la maschera” etc) e in uno dei suoi libri spiega che per i suoi studi si recava tra le tribù aborigene e mostrava loro delle foto di volti che mostravano una certa espressione e chiedeva agli aborigeni di inventare una storia dove il protagonista avesse quello stato emotivo. Non davano un nome all’emozione ma quell’espressione, di paura, o gioia, o disgusto o altro, veniva riconosciuta da ogni cultura, in ogni parte del mondo.
Allora può essere un bel gioco da fare con i bambini quello di mostrare dei visi e dover capire cosa stanno provando e costruirci attorno una storia.
Quando i miei figli erano piccini ci divertivamo, in spiaggia, ad osservare le persone che camminavano in riva al mare e, in base a come gesticolavano parlando tra loro o mentre erano assorti nei loro pensieri, noi li “doppiavamo” immaginando le conversazioni. Per poterlo fare, dovevano riconoscere la mimica dei passanti, la postura, la gestualità e collegarli alle emozioni e ad eventuali pensieri o argomenti.
Quindi, possiamo inventarci dei giochi o porre domande, l’importante è fare in modo che ci siano momenti dove ci si ferma e si ascolta il proprio “sentire” dandogli un nome.
Purtroppo, molti ragazzi provano una profonda sofferenza ma non riescono a descriverla e a definirla dandole un nome a causa di una mancata educazione di osservazione, riconoscimento e accettazione delle proprie emozioni.
Come affermo spesso: i figli meriterebbero tanto amore e genitori preparati.
Fabio Salomoni